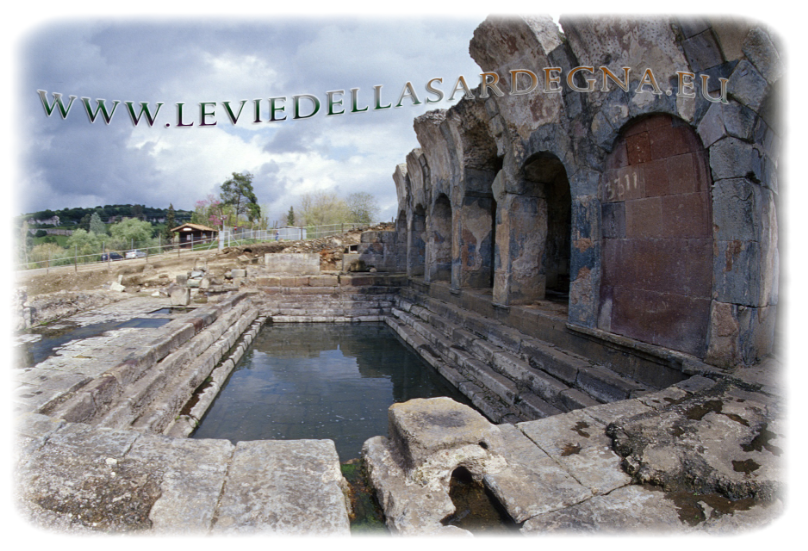I Comuni della Sardegna :: Elenco completo dei comuni della Sardegna in ordine numerico e alfabetico. - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.
Menu principale:
I Comuni della Sardegna :: Elenco completo dei comuni della Sardegna in ordine numerico e alfabetico.
Località

I COMUNI DELLA SARDEGNA
101 Furtei (VS)
102 Gadoni (NU)
103 Gáiro (OG)
104 Galtellì (NU)
105 Gavoi (NU)
106 Genoni (OR)
107 Genuri (VS)
108 Gergei (CA)
109 Gésico (CA)
110 Gésturi (VS)
111 Ghilarza (OR)
112 Giave (SS)
113 Giba (CI)
114 Girasole (OG)
115 Golfo Aranci (OT)
116 Goni (CA)
117 Gonnesa (CI)
118 Gonnoscodina (OR)
119 Gonnosfanádiga (VS)
120 Gonnosnò (OR)
121 Gonnostramatza (OR)
122 Guamaggiore (CA)
123 Guasila (CA)
124 Gúspini (VS)
125 Iglésias (CI)
126 Ilbono (OG)
127 Illorai (SS)
128 Irgoli (NU)
129 Ìsili (CA)
130 Ittireddu (SS)
131 Íttiri (SS)
132 Jerzu (OG)
133 La Maddalena (OT)
134 Láconi (OR)
135 Laerru (SS)
136 Lanusei (OG)
137 Las Plássas (VS)
138 Lei (NU)
139 Loceri (OG)
140 Lóculi (NU)
141 Lodè (NU)
142 Lodine (NU)
143 Loíri Porto San Paolo (OT)
144 Lotzorai (OG)
145 Lula (NU)
146 Lunamatrona (VS)
147 Luogosanto (OT)
148 Lúras (OT)
149 Macomér (NU)
150 Magomádas (OR)
151 Mamoiada (NU)
152 Mándas (CA)
153 Mara (SS)
154 Maracalagónis (CA)
155 Marrúbiu (OR)
156 Mártis (SS)
157 Masaínas (CI)
158 Masúllas (OR)
159 Meana Sardo (NU)
160 Mílis (OR)
161 Módolo (OR)
162 Mogorella (OR)
163 Mógoro (OR)
164 Monastir (CA)
165 Monserrato (CA)
166 Monteleone Rocca Dória (SS)
167 Monti (OT)
168 Montresta (OR)
169 Móres (SS)
170 Morgongiori (OR)
171 Muravera (CA)
172 Muros (SS)
173 Musei (CI)
174 Narbolía (OR)
175 Narcao (CI)
176 Neoneli (OR)
177 Noragúgume (NU)
178 Norbello (OR)
179 Nughedu San Nicolò (SS)
180 Nughedu Santa Vittoria (OR)
181 Nule (SS)
182 Nulvi (SS)
183 Núoro (NU)
184 Nurachi (OR)
185 Nurágus (CA)
186 Nurallao (CA)
187 Nuráminis (CA)
188 Nureci (OR)
189 Nurri (CA)
190 Núxis (CI)
191 Ólbia (OT)
192 Oliena (NU)
193 Ollastra (OR)
194 Ollolai (NU)
195 Olmedo (SS)
196 Olzai (NU)
197 Onanì (NU)
198 Onifai (NU)
199 Oniferi (NU)
200 Orani (NU)
51 Borutta (SS)
52 Bosa (OR)
53 Bottidda (SS)
54 Buddusò (OT)
55 Budoni (OT)
56 Buggerru (CI)
57 Bultei (SS)
58 Bulzi (SS)
59 Burcei (CA)
60 Búrgos (SS)
61 Busachi (OR)
62 Cábras (OR)
63 Cágliari (CA)
64 Calangiánus (OT)
65 Calasetta (CI)
66 Capoterra (CA)
67 Carbónia (CI)
68 Cardedu (OG)
69 Cargeghe (SS)
70 Carloforte (CI)
71 Castelsardo (SS)
72 Castiádas (CA)
73 Cherémule (SS)
74 Chiaramonti (SS)
75 Codrongiános (SS)
76 Collínas (VS)
77 Cossoíne (SS)
78 Cúglieri (OR)
79 Curcúris (OR)
80 Decimomannu (CA)
81 Decimoputzu (CA)
82 Désulo (NU)
83 Dolianova (CA)
84 Dómus De Maria (CA)
85 Domusnóvas (CI)
86 Donori (CA)
87 Dorgali (NU)
88 Dualchi (NU)
89 Elini (OG)
90 Élmas (CA)
91 Érula (SS)
92 Escalaplano (CA)
93 Escolca (CA)
94 Esporlatu (SS)
95 Esterzili (CA)
96 Florínas (SS)
97 Fluminimaggiore (CI)
98 Flussío (OR)
99 Fonni (NU)
100 Fordongiánus (OR)
1 Abbasanta (OR)
2 Ággius (OT)
3 Aglientu (OT)
4 Aidomaggiore (OR)
5 Alà dei Sardi (OT)
6 Albagiara (OR)
7 Áles (OR)
8 Alghero (SS)
9 Állai (OR)
10 Anela (SS)
11 Arboréa (OR)
12 Àrbus (VS)
13 Árdara (SS)
14 Ardaúli (OR)
15 Aritzo (NU)
16 Armúngia (CA)
17 Arzachena (OT)
18 Àrzana (OG)
19 Assemini (CA)
20 Assolo (OR)
21 Asuni (OR)
22 Atzara (NU)
23 Aústis (NU)
24 Badesi (OT)
25 Ballao (CA)
26 Bánari (SS)
27 Barádili (OR)
28 Barátili San Pietro (OR)
29 Baressa (OR)
30 Bari Sardo (OG)
31 Barrali (CA)
32 Barúmini (VS)
33 Bauladu (OR)
34 Baunei (OG)
35 Belvì (NU)
36 Benetutti (SS)
37 Berchidda (OT)
38 Bessude (SS)
39 Bidonì (OR)
40 Bírori (NU)
41 Bitti (NU)
42 Bolótana (NU)
43 Bonárcado (OR)
44 Bonnánaro (SS)
45 Bono (SS)
46 Bonorva (SS)
47 Boroneddu (OR)
48 Bòrore (NU)
49 Bortigali (NU)
50 Bortigiádas (OT)

335 Tramatza (OR)
336 Tratalias (CI)
337 Tresnurághes (OR)
338 Triei (OG)
339 Trinità d’Agultu e Vignola (OT)
340 Tuili (VS)
341 Tula (SS)
342 Turri (VS)
343 Ula Tirso (OR)
344 Ulássai (OG)
345 Ùras (OR)
346 Uri (SS)
347 Urzulei (OG)
348 Uséllus (OR)
349 Ùsini (SS)
350 Ussana (CA)
351 Ussaramanna (VS)
352 Ussássai (OG)
353 Uta (CA)
354 Valledória (SS)
355 Vallermosa (CA)
356 Viddalba (SS)
357 Villa San Pietro (CA)
358 Villa Sant’Antonio (OR)
359 Villa Verde (OR)
360 Villacidro (VS)
361 Villagrande Strisáili (OG)
362 Villamar (VS)
363 Villamassárgia (CI)
364 Villanova Monteleone (SS)
365 Villanova Truschedu (OR)
366 Villanova Tulo (CA)
367 Villanovaforru (VS)
368 Villanovafranca (VS)
369 Villaperúccio (CI)
370 Villaputzu (CA)
371 Villasalto (CA)
372 Villasimíus (CA)
373 Villasor (CA)
374 Villaspeciosa (CA)
375 Villaurbana (OR)
376 Zeddiani (OR)
377 Zerfaliu (OR)
291 Seui (OG)
292 Seúlo (CA)
293 Siamaggiore (OR)
294 Siamanna (OR)
295 Siapiccía (OR)
296 Siddi (VS)
297 Silánus (NU)
298 Síligo (SS)
299 Silíqua (CA)
300 Silíus (CA)
301 Símala (OR)
302 Simáxis (OR)
303 Sindía (NU)
304 Sini (OR)
305 Siniscóla (NU)
306 Sínnai (CA)
307 Síris (OR)
308 Siúrgus Donigala (CA)
309 Soddì (OR)
310 Solarussa (OR)
311 Soléminis (CA)
312 Sórgono (NU)
313 Sorradile (OR)
314 Sorso (SS)
315 Stintino (SS)
316 Suelli (CA)
317 Suni (OR)
318 Tadasuni (OR)
319 Talána (OG)
320 Telti (OT)
321 Témpio Pausánia (OT)
322 Tergu (SS)
323 Terralba (OR)
324 Tertenía (OG)
325 Teti (NU)
326 Teulada (CA)
327 Thiesi (SS)
328 Tíana (NU)
329 Tinnura (OR)
330 Tissi (SS)
331 Tonara (NU)
332 Torpè (NU)
333 Torralba (SS)
334 Tortolì (OG)
201 Orgósolo (NU)
202 Oristano (OR)
203 Orosei (NU)
204 Orotelli (NU)
205 Orroli (CA)
206 Ortacésus (CA)
207 Ortueri (NU)
208 Orune (NU)
209 Òschiri (OT)
210 Osidda (NU)
211 Òsilo (SS)
212 Osini (OG)
213 Ossi (SS)
214 Ottana (NU)
215 Ovodda (NU)
216 Ozieri (SS)
217 Pabillónis (VS)
218 Pádria (SS)
219 Padru (OT)
220 Palau (OT)
221 Pálmas Arboréa (OR)
222 Pattada (SS)
223 Pau (OR)
224 Paúli Arbarei (VS)
225 Paulilátino (OR)
226 Perdasdefogu (OG)
227 Perdáxius (CI)
228 Pérfugas (SS)
229 Pimentél (CA)
230 Piscínas (CI)
231 Ploaghe (SS)
232 Pompu (OR)
233 Porto Tórres (SS)
234 Portoscuso (CI)
235 Posada (NU)
236 Pozzomaggiore (SS)
237 Pula (CA)
238 Putifígari (SS)
239 Quartu Sant’Élena (CA)
240 Quartúcciu (CA)
241 Riola Sardo (OR)
242 Romana (SS)
243 Ruínas (OR)
244 Sádali (CA)
245 Ságama (OR)
246 Samassi (VS)
247 Samatzai (CA)
248 Samugheo (OR)
249 San Basílio (CA)
250 San Gavino Monreale (VS)
251 San Giovanni Suérgiu (CI)
252 San Nicolò d’Arcidano (OR)
253 San Nicolò Gerrei (CA)
254 San Sperate (CA)
255 San Teodoro (OT)
256 San Vero Milis (OR)
257 San Vito (CA)
258 Sanluri (VS)
259 Santa Giusta (OR)
260 Santa Maria Coghínas (SS)
261 Santa Teresa Gallura (OT)
262 Santadi (CI)
263 Sant’Andrea Fríus (CA)
264 Sant’Anna Arresi (CI)
265 Sant’Antíoco (CI)
266 Sant’António di Gallura (OT)
267 Santu Lussúrgiu (OR)
268 Sárdara (VS)
269 Sarròch (CA)
270 Sarule (NU)
271 Sássari (SS)
272 Scano di Montiferro (OR)
273 Sédilo (OR)
274 Sédini (SS)
275 Segariu (VS)
276 Selárgius (CA)
277 Sélegas (CA)
278 Seméstene (SS)
279 Séneghe (OR)
280 Sénis (OR)
281 Sennaríolo (OR)
282 Sénnori (SS)
283 Senorbì (CA)
284 Serdiana (CA)
285 Serramanna (VS)
286 Serrenti (VS)
287 Serri (CA)
288 Sestu (CA)
289 Séttimo San Pietro (CA)
290 Sétzu (VS)


Di Angela Terrosu Asole
STORIA E GEOGRAFIA
DEI COMUNI DELLA SARDEGNA
 Una legge emanata nel 1859, regolamentando nelle terre sottoposte al governo piemontese la giurisdizione degli organismi preposti all’amministrazione pubblica, precisa, tra l’altro, l’organizzazione e i compiti di talune figure giuridiche attinenti all’amministrazione del territorio e cioé delle Province, dei Circondari, dei Mandamenti e dei Comuni. Si trattava di figure talora di nuova istituzione e tra l’altro già esistenti nella pratica: ma è in questo momento che esse acquisiscono un assetto legislativo meglio puntualizzato. Fa parte di quest’ultimo gruppo la figura del Comune, l’unità territoriale più piccola in cui si suddivideva il territorio del regno sardo. La sua originaria creazione, che vede il Comune come espressione della volontà dello Stato, e non di privati cittadini quale era stato nel Medioevo, risale però al secolo XVIII e più precisamente all’anno 1771, quando anche il Piemonte decise di adeguare la propria amministrazione pubblica ai nuovi dettati espressi dalla corrente illuministica. Con questa legge la Sardegna veniva pertanto suddivisa in Comuni, una figura giuridica adottata per segnalare quanto in precedenza era definito più genericamente come villa con le relative pertinenze, espressione usata sin dal Medioevo per indicare da una parte l’area abitativa con la sua popolazione e dall’altra i territori rurali ad essa annessi in funzione agro-pastorale di coloro che risiedevano in quella. Ma se per un verso è molto difficile, soprattutto a causa delle carenze documentarie, stabilire da un punto di vista cronologico il momento della nascita degli attuali villaggi sardi nonché il motivo che vi avrebbe presieduto, ancora più arduo risulta stabilire l’ampiezza dell’agro ad essi collegato. Può darsi che in origine, quando il suolo a disposizione era ancora tantissimo, quest’ampiezza sia stata valutata sulla base di un rapporto tra abitanti e terre da utilizzare per la semina, per il pascolo e per il legnatico, e che quindi le aree di pertinenza abbiano variato con il variare della consistenza demografica del rispettivo villaggio. Ma il succedersi degli eventi dovrebbe aver rotto abbastanza rapidamente questo equilibrio tra produzione e consumo, determinando probabilmente rapporti maggiormente agressivi, quelli determinati dal prevaricare degli abitati più forti su quelli più deboli.
Una legge emanata nel 1859, regolamentando nelle terre sottoposte al governo piemontese la giurisdizione degli organismi preposti all’amministrazione pubblica, precisa, tra l’altro, l’organizzazione e i compiti di talune figure giuridiche attinenti all’amministrazione del territorio e cioé delle Province, dei Circondari, dei Mandamenti e dei Comuni. Si trattava di figure talora di nuova istituzione e tra l’altro già esistenti nella pratica: ma è in questo momento che esse acquisiscono un assetto legislativo meglio puntualizzato. Fa parte di quest’ultimo gruppo la figura del Comune, l’unità territoriale più piccola in cui si suddivideva il territorio del regno sardo. La sua originaria creazione, che vede il Comune come espressione della volontà dello Stato, e non di privati cittadini quale era stato nel Medioevo, risale però al secolo XVIII e più precisamente all’anno 1771, quando anche il Piemonte decise di adeguare la propria amministrazione pubblica ai nuovi dettati espressi dalla corrente illuministica. Con questa legge la Sardegna veniva pertanto suddivisa in Comuni, una figura giuridica adottata per segnalare quanto in precedenza era definito più genericamente come villa con le relative pertinenze, espressione usata sin dal Medioevo per indicare da una parte l’area abitativa con la sua popolazione e dall’altra i territori rurali ad essa annessi in funzione agro-pastorale di coloro che risiedevano in quella. Ma se per un verso è molto difficile, soprattutto a causa delle carenze documentarie, stabilire da un punto di vista cronologico il momento della nascita degli attuali villaggi sardi nonché il motivo che vi avrebbe presieduto, ancora più arduo risulta stabilire l’ampiezza dell’agro ad essi collegato. Può darsi che in origine, quando il suolo a disposizione era ancora tantissimo, quest’ampiezza sia stata valutata sulla base di un rapporto tra abitanti e terre da utilizzare per la semina, per il pascolo e per il legnatico, e che quindi le aree di pertinenza abbiano variato con il variare della consistenza demografica del rispettivo villaggio. Ma il succedersi degli eventi dovrebbe aver rotto abbastanza rapidamente questo equilibrio tra produzione e consumo, determinando probabilmente rapporti maggiormente agressivi, quelli determinati dal prevaricare degli abitati più forti su quelli più deboli. Al tempo di Roma. Per i tempi più remoti, quelli preclassici, per i quali molto poco si sa agli effetti dei villaggi minori, sono tuttavia note le lotte che con frequenza avvenivano tra tribù confinanti proprio per il possesso delle terre, essendo queste non solo un elemento di sicurezza ai fini dell’alimentazione, ma anche un simbolo di potere. Con l’avvento della dominazione punica e poi di quella romana la conoscenza delle aree di pertinenza di ciascun abitato acquisisce una nuova importanza direttamente derivata dall’applicazione del sistema fiscale. È noto, attraverso testimonianze scritte, che i sardi erano tenuti al versamento di più tipi di contributi. Per l’assunto in questione sono importanti i seguenti: quello che dovevano versare a titolo di punizione per la guerra sostenuta contro Roma, ossia lo stipendium , una sorta di tassa sui danni di guerra, che corrispondeva al versamento annuale di un tributo dell’ammontare stabile nel tempo e la cosiddetta “decima”, dovuta in qualità di paese sottoposto a Roma e che già era stata pretesa da Cartagine i secoli della sua dominazione. La riscossione di questi tributi, che nel primo caso avveniva attraverso funzionari statali e nel secondo soprattutto tramite appaltatori privati, vedeva chiamate a risponderne tutte le popolazioni diversamente distribuite nell’isola. È indubbio quindi che Roma disponesse non solo di esatte informazioni nei riguardi del numero di individui che componevano ciascuna popolazione, ma che fosse informata anche sulla loro esatta collocazione territoriale e che avesse, infine, conoscenza dei limiti del territorio rispettivamente occupato. Limiti che erano affidati a documenti scritti nonché a cippi confinari, di cui la copia depositata a Roma presso l’Archivio del Catasto costituiva il punto di riferimento in caso di controversie. Roma, pertanto, aveva valutato la componente territoriale e quella umana, dalla cui fusione sortivano le vaste entità amministrative. Ma quale attenzione dedicava alle piccole unità che pure dovevano esistere? È indubbio che essa dovesse disporre di tutto il quadro insediativo sardo, ed infatti anche per l’isola avrebbe adottato termini di qualificazione assai precisi e puntuali: oppida per segnalare le città, pagi per individuare i villaggi, vici per contraddistinguere gli agglomerati minori e forum per annotare i coaguli di tipo anche commerciale. Poco si sa, invece, nei riguardi delle estensioni territoriali che erano loro legate e, soprattutto, se queste fossero esattamente delimitate. Nessun lume proviene nemmeno dall’istituto della centuriato che la città del Tevere certamente realizzò anche in Sardegna, quantomeno nel retroterra di Turris Libisonis (attuale Porto Torres) e di Tharros, ma di cui ben poco è rimasto sul terreno, se si esclude il tratto immediatamente afferente al complesso urbano turritano. Non si conoscono, infatti, i valori delle maglie dei reticolati sardi, come neppure si hanno valutazioni che aiutino ad individuare il saltus verso cui l’area lottizzata sconfinava. Riepilogando quanto al momento attuale è dato sapere nei riguardi delle piccole unità amministrative durante l’età classica si è costretti a riconoscere una situazione di totale incertezza agli effetti dei terreni che comunque anche allora erano certamente legati ad ogni forma di vita abitativa.
Al tempo di Roma. Per i tempi più remoti, quelli preclassici, per i quali molto poco si sa agli effetti dei villaggi minori, sono tuttavia note le lotte che con frequenza avvenivano tra tribù confinanti proprio per il possesso delle terre, essendo queste non solo un elemento di sicurezza ai fini dell’alimentazione, ma anche un simbolo di potere. Con l’avvento della dominazione punica e poi di quella romana la conoscenza delle aree di pertinenza di ciascun abitato acquisisce una nuova importanza direttamente derivata dall’applicazione del sistema fiscale. È noto, attraverso testimonianze scritte, che i sardi erano tenuti al versamento di più tipi di contributi. Per l’assunto in questione sono importanti i seguenti: quello che dovevano versare a titolo di punizione per la guerra sostenuta contro Roma, ossia lo stipendium , una sorta di tassa sui danni di guerra, che corrispondeva al versamento annuale di un tributo dell’ammontare stabile nel tempo e la cosiddetta “decima”, dovuta in qualità di paese sottoposto a Roma e che già era stata pretesa da Cartagine i secoli della sua dominazione. La riscossione di questi tributi, che nel primo caso avveniva attraverso funzionari statali e nel secondo soprattutto tramite appaltatori privati, vedeva chiamate a risponderne tutte le popolazioni diversamente distribuite nell’isola. È indubbio quindi che Roma disponesse non solo di esatte informazioni nei riguardi del numero di individui che componevano ciascuna popolazione, ma che fosse informata anche sulla loro esatta collocazione territoriale e che avesse, infine, conoscenza dei limiti del territorio rispettivamente occupato. Limiti che erano affidati a documenti scritti nonché a cippi confinari, di cui la copia depositata a Roma presso l’Archivio del Catasto costituiva il punto di riferimento in caso di controversie. Roma, pertanto, aveva valutato la componente territoriale e quella umana, dalla cui fusione sortivano le vaste entità amministrative. Ma quale attenzione dedicava alle piccole unità che pure dovevano esistere? È indubbio che essa dovesse disporre di tutto il quadro insediativo sardo, ed infatti anche per l’isola avrebbe adottato termini di qualificazione assai precisi e puntuali: oppida per segnalare le città, pagi per individuare i villaggi, vici per contraddistinguere gli agglomerati minori e forum per annotare i coaguli di tipo anche commerciale. Poco si sa, invece, nei riguardi delle estensioni territoriali che erano loro legate e, soprattutto, se queste fossero esattamente delimitate. Nessun lume proviene nemmeno dall’istituto della centuriato che la città del Tevere certamente realizzò anche in Sardegna, quantomeno nel retroterra di Turris Libisonis (attuale Porto Torres) e di Tharros, ma di cui ben poco è rimasto sul terreno, se si esclude il tratto immediatamente afferente al complesso urbano turritano. Non si conoscono, infatti, i valori delle maglie dei reticolati sardi, come neppure si hanno valutazioni che aiutino ad individuare il saltus verso cui l’area lottizzata sconfinava. Riepilogando quanto al momento attuale è dato sapere nei riguardi delle piccole unità amministrative durante l’età classica si è costretti a riconoscere una situazione di totale incertezza agli effetti dei terreni che comunque anche allora erano certamente legati ad ogni forma di vita abitativa.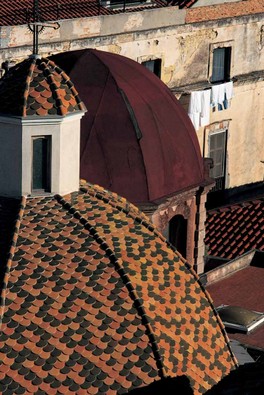 Il Medioevo. Purtroppo a questo riguardo le lacune permangono a lungo anche per i tempi successivi, come, ad esempio, quelli relativi al periodo della influenza pisana, per i quali più tipi di fonti, ed in particolar modo quelle fiscali, risultano notevolmente generose di dati e di informazioni. Queste fonti hanno infatti consentito la ricostruzione di tutte le ville, ossia degli abitati maggiori, nonché di un numero abbastanza notevole, anche se non certo completo, di agglomerati minori o, come allora si definivano, di domestie e di donnicalie. L’incompletezza delle informazioni specifiche rende tuttavia limitatamente utilizzabili anche i dati forniti dai registri dei tributi redatti da Pisa per i suoi possedimenti sardi. Ormai si sa che le imposizioni fiscali corrispondevano a una percentuale: probabilmente ancora una volta la decima parte delle rese che mediamente erano in grado di raggiungere le produzioni cerealicole e quasi certamente anche quelle viticole. Questa percentuale rimase invariata a lungo come, del resto, rimase la valutazione delle rese medie. Tale tipo di valutazione non richiedeva, infatti, frequenti opere di aggiornamento. Queste sarebbero state pretese, tutt’al più, se si fosse avuta la messa a coltura di nuove, vaste estensioni territoriali o se l’intervento di più moderne tecniche avesse rivoluzionato i calcoli delle rese medie precedenti. L’ingegnoso sistema fiscale adottato da Pisa, facendo sì che a rispondere di fronte al Comune toscano non fossero i singoli produttori, ma i rappresentanti delle comunità, i quali, a loro volta, si rifacevano sui singoli, e più ancora che l’elemento maggiormente significativo fosse il prodotto, e non il suolo che pur dava luogo al prodotto, ha distratto la documentazione e impedito per lunghissimo tempo sia la nascita di una cartografia rurale sia la scrittura di documenti relativi alla delineazione dei confini dei villaggi. Lo prova l’esistenza di una pur copiosa documentazione che tuttavia accenna solo in modo generico alle “pertinenze territoriali” delle ville sarde e, di contro, il silenzio pressoché assoluto sulla loro ampiezza e delimitazione. Una situazione quindi alquanto ambigua, almeno all’origine, che dovrebbe aver dato luogo a non pochi soprusi di cui rimane qualche traccia seppur rara nelle fonti relative alle liti sorte per questioni di confine tra villaggi limitrofi. L’uso di delimitare per iscritto i terreni tuttavia esisteva ma, come nel periodo romano, solo agli effetti di vaste superfici. Così quando nel secolo XII Torchitorio, giudice di Cagliari, fece donazione al figlio Salusio di Lacon della Incontrada di Trexenta, in previsione del matrimonio che questi doveva contrarre con Adelasia di Torres, alla presenza di un notaio fu stilato un atto nel quale vennero precisati i confini dell’area donata e le relative caratteristiche. Da questo atto si può dedurre che il territorio mediamente annesso ad ogni abitato in questa prospera area dell’isola corrispondeva a circa 700 ettari. Una superficie che differiva da quella attuale in quanto nel secolo XIII, allorché il documento fu steso, il numero delle ville che facevano parte di questa regione era pari a una quarantina (contro gli attuali 13 comuni): fatto, comunque, che non presume processi di risuddivisione, ma che andrebbe piuttosto collegato alla tradizione sarda che voleva i suoli di pertinenza dei villaggi di decadenza legati amministrativamente all’abitato adiacente, in cui confluivano le genti dei centri abbandonati. Il dato medio scaturito dal documento relativo alla Trexenta naturalmente non ha valore per tutta la Sardegna.
Il Medioevo. Purtroppo a questo riguardo le lacune permangono a lungo anche per i tempi successivi, come, ad esempio, quelli relativi al periodo della influenza pisana, per i quali più tipi di fonti, ed in particolar modo quelle fiscali, risultano notevolmente generose di dati e di informazioni. Queste fonti hanno infatti consentito la ricostruzione di tutte le ville, ossia degli abitati maggiori, nonché di un numero abbastanza notevole, anche se non certo completo, di agglomerati minori o, come allora si definivano, di domestie e di donnicalie. L’incompletezza delle informazioni specifiche rende tuttavia limitatamente utilizzabili anche i dati forniti dai registri dei tributi redatti da Pisa per i suoi possedimenti sardi. Ormai si sa che le imposizioni fiscali corrispondevano a una percentuale: probabilmente ancora una volta la decima parte delle rese che mediamente erano in grado di raggiungere le produzioni cerealicole e quasi certamente anche quelle viticole. Questa percentuale rimase invariata a lungo come, del resto, rimase la valutazione delle rese medie. Tale tipo di valutazione non richiedeva, infatti, frequenti opere di aggiornamento. Queste sarebbero state pretese, tutt’al più, se si fosse avuta la messa a coltura di nuove, vaste estensioni territoriali o se l’intervento di più moderne tecniche avesse rivoluzionato i calcoli delle rese medie precedenti. L’ingegnoso sistema fiscale adottato da Pisa, facendo sì che a rispondere di fronte al Comune toscano non fossero i singoli produttori, ma i rappresentanti delle comunità, i quali, a loro volta, si rifacevano sui singoli, e più ancora che l’elemento maggiormente significativo fosse il prodotto, e non il suolo che pur dava luogo al prodotto, ha distratto la documentazione e impedito per lunghissimo tempo sia la nascita di una cartografia rurale sia la scrittura di documenti relativi alla delineazione dei confini dei villaggi. Lo prova l’esistenza di una pur copiosa documentazione che tuttavia accenna solo in modo generico alle “pertinenze territoriali” delle ville sarde e, di contro, il silenzio pressoché assoluto sulla loro ampiezza e delimitazione. Una situazione quindi alquanto ambigua, almeno all’origine, che dovrebbe aver dato luogo a non pochi soprusi di cui rimane qualche traccia seppur rara nelle fonti relative alle liti sorte per questioni di confine tra villaggi limitrofi. L’uso di delimitare per iscritto i terreni tuttavia esisteva ma, come nel periodo romano, solo agli effetti di vaste superfici. Così quando nel secolo XII Torchitorio, giudice di Cagliari, fece donazione al figlio Salusio di Lacon della Incontrada di Trexenta, in previsione del matrimonio che questi doveva contrarre con Adelasia di Torres, alla presenza di un notaio fu stilato un atto nel quale vennero precisati i confini dell’area donata e le relative caratteristiche. Da questo atto si può dedurre che il territorio mediamente annesso ad ogni abitato in questa prospera area dell’isola corrispondeva a circa 700 ettari. Una superficie che differiva da quella attuale in quanto nel secolo XIII, allorché il documento fu steso, il numero delle ville che facevano parte di questa regione era pari a una quarantina (contro gli attuali 13 comuni): fatto, comunque, che non presume processi di risuddivisione, ma che andrebbe piuttosto collegato alla tradizione sarda che voleva i suoli di pertinenza dei villaggi di decadenza legati amministrativamente all’abitato adiacente, in cui confluivano le genti dei centri abbandonati. Il dato medio scaturito dal documento relativo alla Trexenta naturalmente non ha valore per tutta la Sardegna.  La dimensione territoriale di ogni villaggio, dovendo garantire, come si è detto, l’alimentazione a coloro che risiedevano nella parte edificata, necessariamente variava a seconda della fertilità dei suoli. Ne consegue che le pertinenze degli abitati siti nelle sassose aree di montagna erano, come del resto ancora oggi, assai vaste, mentre erano piuttosto piccole quelle che si distendevano sui prosperi suoli delle piatte superfici del Campidano. L’impressione che tuttavia si evince da questo documento è data dal prevalere di confini di tipo morfologico. Confini, cioé, appoggiati in primo luogo a crinali di rilievi e a corsi d’acqua, e solo secondariamente a strade. Altra impressione è data da un certo prevalere del potere contrattuale degli abitanti più forti, i quali sarebbero riusciti a far coincidere con delineazioni per loro più convenienti i confini delle terre appartenenti ai propri villaggi. Ugualmente appoggiati a elementi soprattutto fisici risultano i confini delle vaste aree agricole che nei primi secoli dell’attuale Millennio sono state donate dalle autorità governative sarde a Ordini religiosi per lo più della Penisola. Questi confini, la cui delimitazione è a noi pervenuta attraverso i Condaghi, cioé registri tenuti da monasteri, appaiono infatti affidati soprattutto a corsi d’acqua, a guadi, a emergenze del terreno, a sorgenti, ad alberi isolati, ecc., ma anche a nuraghi, chiese, proprietà private, pietre miliari, viottoli campestri. Comunque anche questo tipo di fonti, per tanti versi preziosissimo proprio nei riguardi di uno studio sulle delimitazioni delle aree agrarie, non contiene segnalazioni precise circa i confini dei territori legati ai villaggi. Nessuna informazione proviene nemmeno dall’atto di fondazione del villaggio di Burgos, risalente al 1353. L’atto precisa che il giudice Mariano d’Arborea si premurò di dotarlo dei necessari terreni per il seminerio, l’allevamento e il legnatico, ma non contiene la delineazione dei confini e rimanda per questo argomento ad un’altra fonte, forse cartografica, che purtroppo si è persa.
La dimensione territoriale di ogni villaggio, dovendo garantire, come si è detto, l’alimentazione a coloro che risiedevano nella parte edificata, necessariamente variava a seconda della fertilità dei suoli. Ne consegue che le pertinenze degli abitati siti nelle sassose aree di montagna erano, come del resto ancora oggi, assai vaste, mentre erano piuttosto piccole quelle che si distendevano sui prosperi suoli delle piatte superfici del Campidano. L’impressione che tuttavia si evince da questo documento è data dal prevalere di confini di tipo morfologico. Confini, cioé, appoggiati in primo luogo a crinali di rilievi e a corsi d’acqua, e solo secondariamente a strade. Altra impressione è data da un certo prevalere del potere contrattuale degli abitanti più forti, i quali sarebbero riusciti a far coincidere con delineazioni per loro più convenienti i confini delle terre appartenenti ai propri villaggi. Ugualmente appoggiati a elementi soprattutto fisici risultano i confini delle vaste aree agricole che nei primi secoli dell’attuale Millennio sono state donate dalle autorità governative sarde a Ordini religiosi per lo più della Penisola. Questi confini, la cui delimitazione è a noi pervenuta attraverso i Condaghi, cioé registri tenuti da monasteri, appaiono infatti affidati soprattutto a corsi d’acqua, a guadi, a emergenze del terreno, a sorgenti, ad alberi isolati, ecc., ma anche a nuraghi, chiese, proprietà private, pietre miliari, viottoli campestri. Comunque anche questo tipo di fonti, per tanti versi preziosissimo proprio nei riguardi di uno studio sulle delimitazioni delle aree agrarie, non contiene segnalazioni precise circa i confini dei territori legati ai villaggi. Nessuna informazione proviene nemmeno dall’atto di fondazione del villaggio di Burgos, risalente al 1353. L’atto precisa che il giudice Mariano d’Arborea si premurò di dotarlo dei necessari terreni per il seminerio, l’allevamento e il legnatico, ma non contiene la delineazione dei confini e rimanda per questo argomento ad un’altra fonte, forse cartografica, che purtroppo si è persa. Dalla Spagna al catasto dell’Ottocento. La situazione non cambiò con l’avvento della dominazione spagnola, che sembra abbia accettato e fatto suo il criterio fiscale studiato da Pisa: un criterio tra l’altro che ha impedito lo svilupparsi in Sardegna di una cartografia regionale a grande scala, come invece è avvenuto nelle regioni italiane sottoposte al sistema di tassazione basato sull’idoneità all’utilizzo rurale dei complessi prediali. Se si opera una comparazione tra i registri fiscali pisani e quelli spagnoli non si notano infatti eccessive disparità nell’entità dei versamenti. A porre fine allo stato di precarietà nella definizione delle aree di pertinenza dei singoli abitati intervenne finalmente, ma si è già nell’Ottocento avanzato, una legge emanata dal Governo piemontese nel 1839, mirante alla applicazione del Catasto prediale in Sardegna, allo scopo di equiparare il sistema tributario sardo con quello degli Stati sabaudi di terraferma. L’incarico di tradurre la legge in realtà operativa fu affidato a Carlo De Candia, un ufficiale del Genio militare che si valse di una équipe di tecnici per gran parte provenienti dal suo stesso corpo. Per poter portare a compimento l’opera, destinata a costruire finalmente una cartografia specifica ed a grande scala, era indispensabile la conoscenza esatta dei territori legati a ogni villaggio e quindi in primo luogo la loro delimitazione: un’operazione che la mancanza di atti precedentemente scritti rese lunga e complessa. Il De Candia, infatti, nella maggior parte dei casi fu costretto a basarsi sulle tradizioni orali che, alla presenza di un delegato governativo, venivano esposte e commentate dal Consiglio comunitativo, sindaco compreso, dei villaggi di volta in volta considerati, nonché di quelli ad essi limitrofi.
Dalla Spagna al catasto dell’Ottocento. La situazione non cambiò con l’avvento della dominazione spagnola, che sembra abbia accettato e fatto suo il criterio fiscale studiato da Pisa: un criterio tra l’altro che ha impedito lo svilupparsi in Sardegna di una cartografia regionale a grande scala, come invece è avvenuto nelle regioni italiane sottoposte al sistema di tassazione basato sull’idoneità all’utilizzo rurale dei complessi prediali. Se si opera una comparazione tra i registri fiscali pisani e quelli spagnoli non si notano infatti eccessive disparità nell’entità dei versamenti. A porre fine allo stato di precarietà nella definizione delle aree di pertinenza dei singoli abitati intervenne finalmente, ma si è già nell’Ottocento avanzato, una legge emanata dal Governo piemontese nel 1839, mirante alla applicazione del Catasto prediale in Sardegna, allo scopo di equiparare il sistema tributario sardo con quello degli Stati sabaudi di terraferma. L’incarico di tradurre la legge in realtà operativa fu affidato a Carlo De Candia, un ufficiale del Genio militare che si valse di una équipe di tecnici per gran parte provenienti dal suo stesso corpo. Per poter portare a compimento l’opera, destinata a costruire finalmente una cartografia specifica ed a grande scala, era indispensabile la conoscenza esatta dei territori legati a ogni villaggio e quindi in primo luogo la loro delimitazione: un’operazione che la mancanza di atti precedentemente scritti rese lunga e complessa. Il De Candia, infatti, nella maggior parte dei casi fu costretto a basarsi sulle tradizioni orali che, alla presenza di un delegato governativo, venivano esposte e commentate dal Consiglio comunitativo, sindaco compreso, dei villaggi di volta in volta considerati, nonché di quelli ad essi limitrofi.  Quanto realizzato dal De Candia fu reso esecutivo mediante la già ricordata legge del 1859 e, pur dando luogo a molteplici contestazioni — qualcuna persiste tuttora —, pose fine alle tantissime incertezze fino ad allora sussistenti nei riguardi, appunto, dell’ampiezza delle pertinenze territoriali spettanti ad ogni singolo abitato. All’atto della promulgazione della legge che, nel marzo del 1861, in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia, divenne legge nazionale, fu ufficialmente ribadita l’esistenza di una unità amministrativa minore chiamata Comune. Dal punto di vista territoriale essa si articola, come i precedenti villaggi, in due parti: una relativa all’area ricoperta dalle strutture edilizie ed una seconda che riguarda la superficie genericamente definita rurale. Nel 1859, allorché la legge entrò in vigore, fu stabilito il riconoscimento di 371 comuni, di cui 334 composti da una sola parte abitativa e da una territoriale e 37 risultanti dall’accorpamento di più agglomerati demografici con le relative pertinenze. In quel momento la superficie media spettante a ogni comune risultò pari a 6466 ettari, ma le sperequazioni tra un comune e l’altro risultatorono enormi. Mentre il centro gallurese di Tempio Pausania si trovò, ad esempio, a poter disporre di un agro comunale pari a ben 90.670 ettari, Modolo, un villaggio della Planargia, pur potendo contare su terreni più fertili, dovette accontentarsi di soli 252 ettari. Le disuguaglianze risultarono notevoli anche agli effetti di vaste superfici. Nella provincia di Cagliari, infatti, ad ogni comune era mediamente legata un’area pari a 5.140 ettari,
Quanto realizzato dal De Candia fu reso esecutivo mediante la già ricordata legge del 1859 e, pur dando luogo a molteplici contestazioni — qualcuna persiste tuttora —, pose fine alle tantissime incertezze fino ad allora sussistenti nei riguardi, appunto, dell’ampiezza delle pertinenze territoriali spettanti ad ogni singolo abitato. All’atto della promulgazione della legge che, nel marzo del 1861, in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia, divenne legge nazionale, fu ufficialmente ribadita l’esistenza di una unità amministrativa minore chiamata Comune. Dal punto di vista territoriale essa si articola, come i precedenti villaggi, in due parti: una relativa all’area ricoperta dalle strutture edilizie ed una seconda che riguarda la superficie genericamente definita rurale. Nel 1859, allorché la legge entrò in vigore, fu stabilito il riconoscimento di 371 comuni, di cui 334 composti da una sola parte abitativa e da una territoriale e 37 risultanti dall’accorpamento di più agglomerati demografici con le relative pertinenze. In quel momento la superficie media spettante a ogni comune risultò pari a 6466 ettari, ma le sperequazioni tra un comune e l’altro risultatorono enormi. Mentre il centro gallurese di Tempio Pausania si trovò, ad esempio, a poter disporre di un agro comunale pari a ben 90.670 ettari, Modolo, un villaggio della Planargia, pur potendo contare su terreni più fertili, dovette accontentarsi di soli 252 ettari. Le disuguaglianze risultarono notevoli anche agli effetti di vaste superfici. Nella provincia di Cagliari, infatti, ad ogni comune era mediamente legata un’area pari a 5.140 ettari,  mentre nella provincia di Sassari i valori risultarono ben più alti: 9.704 ettari per ogni unità comunale. Nel corso degli ultimi centoventicinque anni la situazione ha subìto numerose variazioni. Si è, ad esempio, avuta una notevolissima contrazione nel numero dei comuni nel corso del 1927 per effetto della legge del 17 marzo 1927, che tendeva alla centralizzazione degli uffici comunali. In quel momento i comuni sardi calarono a 275, suddivisi in tre province: quella di Cagliari, quella di Sassari e quella di Nuoro, istituita nello stesso 1927. Successivamente il numero ha ripreso ad accrescersi, perché si è cercato di ottemperare alle richieste di popolazioni che da un lato speravano di trarre maggiori vantaggi da una amministrazione autonoma e dall’altro ambivano a disporre di servizi amministrativi sufficientemente vicini. All’atto del censimento del 1981 la Sardegna risultava suddivisa in 357 unità comunali, a loro volta ripartite in quattro province (quella di Oristano è stata istituita nel 1974). Di queste unità 102 erano ubicate nella provincia di Cagliari e disponevano mediamente di 6.760 ettari ciascuna; 102 si trovavano nella provincia di Nuoro e avevano a disposizione in media 6.906 ettari; 75 erano nella provincia di Oristano, con una superficie media pari a 3.507 ettari; e infine 78 rappresentavano le unità della provincia di Sassari, con una media di 9.641 ettari ciascuna.
mentre nella provincia di Sassari i valori risultarono ben più alti: 9.704 ettari per ogni unità comunale. Nel corso degli ultimi centoventicinque anni la situazione ha subìto numerose variazioni. Si è, ad esempio, avuta una notevolissima contrazione nel numero dei comuni nel corso del 1927 per effetto della legge del 17 marzo 1927, che tendeva alla centralizzazione degli uffici comunali. In quel momento i comuni sardi calarono a 275, suddivisi in tre province: quella di Cagliari, quella di Sassari e quella di Nuoro, istituita nello stesso 1927. Successivamente il numero ha ripreso ad accrescersi, perché si è cercato di ottemperare alle richieste di popolazioni che da un lato speravano di trarre maggiori vantaggi da una amministrazione autonoma e dall’altro ambivano a disporre di servizi amministrativi sufficientemente vicini. All’atto del censimento del 1981 la Sardegna risultava suddivisa in 357 unità comunali, a loro volta ripartite in quattro province (quella di Oristano è stata istituita nel 1974). Di queste unità 102 erano ubicate nella provincia di Cagliari e disponevano mediamente di 6.760 ettari ciascuna; 102 si trovavano nella provincia di Nuoro e avevano a disposizione in media 6.906 ettari; 75 erano nella provincia di Oristano, con una superficie media pari a 3.507 ettari; e infine 78 rappresentavano le unità della provincia di Sassari, con una media di 9.641 ettari ciascuna.I Comuni della Sardegna oggi.
[Una ulteriore esigenza di autonomia locale ha condotto in anni più recenti alla creazione di ben quattro nuove province sulla base di una legge regionale del 2001 hanno così avuto vita, tutte con sede del capoluogo suddivisa tra due centri: quella di Olbia- Tempio o della Gallura, a spese quasi per intero di quella di Sassari; quella del Medio Campidano o di Villacidro-Sanluri, da territori di quella di Cagliari; quella dell’Ogliastra o di Tortolì-Lanusei, a spese della provincia di Nuoro; e quella del Sulcis, o Carbonia-Iglesias, anch’essa con comuni già appartenuti a quella di Cagliari. Questa quindi la nuova suddivisione: provincia di Sassari con 66 comuni; Gallura o Olbia-Tempio con 26; Nuoro con 52; Oristano con 88; Medio Campidano o Villacidro-Sanluri con 28; Ogliastra o Tortolì-Lanusei con 23; Cagliari con 71; Sulcis o Carbonia-Iglesias con 23. In totale esistono oggi in Sardegna: 377 comuni suddivisi in otto circoscrizioni provinciali].